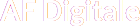Se oltre che appassionati di Alta Fedeltà siete anche sostenitori dell’analogico non potete non conoscere la codifica RIAA, per certi versi l’essenza stessa del suono di un disco in vinile, giacché proprio a questa importante codifica si deve l’esistenza dello stadio Fono.
Dovesse sfuggirvi o addirittura non sapere di cosa si tratta esattamente – magari siete nati in era digitale e la cosa non vi ha mai sfiorato – nel presente articolo cercheremo di far luce su questo essenziale circuito nel modo più semplice possibile.
Immancabilmente presente a bordo di qualsiasi amplificatore o preamplificatore – prima che l’era digitale ne decretasse per qualche tempo la temporanea sparizione – il circuito a standard RIAA (acronimo di Recording Industry Association of America) è alla base della triade analogica composta da fonorivelatore, braccio e giradischi, elementi più o meno sofisticati di qualsiasi sorgente analogica.
A prescindere quindi dalla qualità dei citati componenti – che chiaramente si suppone almeno decente – spetta a questa parte dell’elettronica tradurre il delicato segnale estratto dal disco in vinile ad opera della testina in suadente musica.

Infatti, se riproducessimo un disco in vinile senza il contributo del circuito RIAA l’ascolto sarebbe impossibile, tanto sovrabbondanti sarebbero le alte frequenze in confronto alle basse, praticamente assenti; tutto avremmo tranne che un suono ad Alta Fedeltà.
Lo standard nasce nel 1954 e si spiega con la necessità, per motivi strettamente tecnici, di ridurre, ovvero esaltare determinate frequenze con lo scopo di poterle incidere sul disco, diversamente non sarebbe possibile a causa delle eccessive (o ridottissime) escursioni che il fonorivelatore dovrebbe compiere durante la lettura del solco, praticamente impossibile da tracciare.
Il successivo ripristino del segnale originale – compito importantissimo come è facile intuire – è demandato pertanto al circuito RIAA, che attraverso una serie di componenti più o meno sofisticati – ed in base alla tecnologia con cui è realizzato, siano essi operazionali, stato solido oppure valvole – si occuperà di restituire al delicato segnale analogico l’originale ampiezza, nella speranza che tale azione sia il più possibile accurata, ovvero compresa entro quel minimo di alterazione cui è impossibile sfuggire; diciamo che i migliori stadi fono operano anche entro 0.1 dB di alterazione con una media di 0.5/1 dB, tutto sommato valori assolutamente accettabili.
Piccola curiosità: un costoso stadio fono a valvole realizzato da una conosciuta azienda europea i cui prodotti non sono certamente definibili come economici, in dipendenza del carico del fonorivelatore vanta alle misure un dislivello la cui ampiezza raggiunge un massimo di circa 5 dB (!) compreso tra i 20Hz e i 50Hz (!!), il che significa che qualsiasi confronto con altri stadi sarà immancabilmente a favore di questo, se non altro per la consistenza delle basse frequenze, indubbiamente “aiutate” da questa considerevole non-linearità.
Sebbene tale elevata discrepanza dovrebbe essere considerata grave, la suddetta elettronica – di cui non facciamo il nome al fine di non generare inutili polemiche – è considerata tra le migliori disponibili sul mercato; ed in effetti lo è!

Sia come sia, osservando l’immagine sovrastante è possibile comprendere al volo il discorso – laddove a partire da un punto centrale posto a 1000Hz – in fase di registrazione il segnale analogico subirà una sorta di inclinazione che impone un’elevata esaltazione lato alte frequenze corrispondente ad altrettanta attenuazione lato basse; lo stadio fono eseguirà esattamente l’operazione contraria.
In altre parole, si applica un’attenuazione di circa 20 dB alla parte bassa dello spettro cui corrisponde un’esaltazione dello stesso valore per quanto riguarda la parte alta ed il motivo è abbastanza chiaro: l’obiettivo è quello di limitare il movimento del cantilever – la sottile asta su cui è collocato il diamante – onde rendere più facile la lettura del solco da parte del fonorivelatore.
Al contempo ciò consente di risparmiare spazio sulla facciata del disco, poiché la fisica riduzione della dimensione dei solchi consente di incidere più musica su una singola facciata.
Pertanto, se la cosa rende la vita del pick-up estremamente più semplice, va da sé che fondamentale deve essere la cura con cui lo stadio RIAA restituisce l’originale livello alle suddette frequenze, che laddove non fosse esattamente quello previsto darebbe luogo ad interpretazioni eccessivamente arbitrarie di quanto registrato sulla superficie del disco.

Per completezza di informazione, sappiate che precedentemente allo standard RIAA esistevano ed erano applicate altre tipologie di curve – ad esempio DECCA, anche nota come FFRR (Full Frequency Range Recording) oppure COLUMBIA – caratterizzate da diversi punti di intervento in relazione alle frequenze e disponibili ancora oggi in qualche stadio fono particolarmente sofisticato.
In conclusione quindi, la realizzazione (o meglio la prestazione) del circuito RIAA è assolutamente essenziale onde riprodurre il segnale analogico nella maniera migliore, motivo che impone un’attenzione particolare nel momento di scegliere un amplificatore che già contenga il citato stadio al suo interno – sovente proposto in versione MM e MC – ovvero si preferisca un esemplare separato, molto spesso più gestibile dal punto di vista delle regolazioni elettriche pertinenti capacità e resistenza degli ingressi.
Come al solito, ottimi ascolti!!!
© 2025, MBEditore – TPFF srl. Riproduzione riservata.