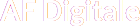I 5 pregiudizi che impediscono agli audiofili più passatisti di accettare l’amplificazione in Classe D. Dai miti sul “digitale” alle nuove frontiere GaN e Purifi, ecco perché il vostro “orecchio d’oro” vi sta mentendo
Se c’è un luogo dove la scienza viene spesso sacrificata sull’altare della stregoneria, questo è il salotto dell’audiofilo esoterico “vecchia scuola”. È un luogo sacro, illuminato dalla flebile luce arancione di valvole termoioniche che scaldano come stufe a kerosene, dove cavi spessi come anaconde vengono sollevati da terra tramite supporti in ceramica per evitare le vibrazioni del pavimento. In questo tempio dell’analogico, pronunciare la temuta formula “Classe D” equivale quasi a bestemmiare in chiesa durante l’omelia domenicale.
Eppure, siamo a fine 2025 e la tecnologia ha fatto passi da gigante che rendono i vecchi paradigmi non solo obsoleti ma quasi ridicoli. Tuttavia, la resistenza è feroce. Ho passato anni a discutere con appassionati che preferirebbero ascoltare musica attraverso un citofono in Classe A piuttosto che ammettere che un modulo switching moderno possa suonare bene. Una titubanza che non è cautela, ma un mix di poca conoscenza tecnica, snobismo elitario e attaccamento feticistico al passato.
Ho quindi pensato di analizzare i motivi per cui alcuni audiofili sono ancora “terrorizzati” dalla Classe D, cercando di dimostrare al tempo stesso perché questi timori siano ormai infondati quanto la credenza che la Terra sia piatta (oddio, i terrapiattisti ancora ci sono… ma avete capito il senso).

L’equivoco semantico: la D non sta per digitale
Il primo scoglio è puramente culturale e denota una chiara pigrizia intellettuale. Chiedete a un detrattore il motivo per cui odia la Classe D e vi risponderà con un sorrisetto di sufficienza: “Perché il suono è digitale, è a scalini, manca l’anima dell’onda sinusoidale pura”.
Primo grave errore visto che la Classe D è analogica. Il segnale in ingresso viene modulato in larghezza di impulso (PWM – Pulse Width Modulation) e anche se ci sono due stati (acceso/spento), la larghezza di quegli impulsi è una variabile analogica continua nel tempo. Non c’è quantizzazione, non ci sono bit, non c’è campionamento nel senso PCM del termine. È un’onda quadra che, una volta passata attraverso un filtro passa-basso in uscita (induttore e condensatore), restituisce il segnale musicale amplificato.
L’audiofilo vecchio stile immagina il segnale come una scalinata di LEGO spigolosi che aggrediscono i suoi preziosi tweeter al berillio. La realtà è che i moderni moduli di amplificazione, come gli Hypex NCore o i più recenti Purifi Eigentakt (progettati da quel genio di Bruno Putzeys), lavorano a frequenze di commutazione così elevate (spesso nell’ordine del MHz) che la risoluzione temporale è virtualmente infinita rispetto alla banda audio udibile.

Il pregiudizio qui nasce dalla confusione con gli amplificatori completamente digitali (i cosiddetti PowerDAC come il NAD M32 con la sua tecnologia DirectDigital), che sono una bestia diversa. Ma rifiutare l’ampli-streamer NAD M33 o un finale basato su moduli Nilai perché “è digitale” è come rifiutare un’auto elettrica perché si ha paura che il cavallo nel cofano non respiri. È un errore di categoria ontologico. Eppure, la narrazione del “suono freddo e digitale” persiste.
Il trauma del passato: lo spettro del T-Amp e la “freddezza” clinica
Bisogna essere onesti: vent’anni fa, la Classe D era in effetti poca cosa. O meglio, era ancora molto acerba. Ricordate il famoso T-Amp basato sul chip Tripath TA2024 con la sua “Classe T”, che altro non era se non una variazione proprietaria della Classe D? Costava come una pizza, stava nel palmo di una mano e, per quello che costava, era un miracolo. Ma se si provava a pilotare diffusori seri con questa scatolina, il basso spariva, gli alti erano vetrosi come una lastra di ghiaccio e la distorsione ad alta frequenza era udibile anche da un pipistrello sordo.
Molti audiofili hanno avuto la loro prima e unica esperienza con la Classe D in quell’epoca, o magari con i primi moduli ICEpower non ancora raffinati. Hanno ascoltato quel suono aspro, granuloso sulle voci e privo di profondità scenica e hanno emesso una sentenza a vita: “La Classe D va bene per i subwoofer, non per la musica vera”.
Questo però è snobismo temporale e per fortuna la tecnologia di commutazione odierna non ha nulla a che vedere con quella di inizio millennio. Prendiamo i più recenti amplificatori basati su transistor GaN (Gallium Nitride), come quelli implementati da Peachtree Audio o nell’HiFi Rose RA180. La velocità di commutazione dei FET al nitruro di gallio è talmente elevata e il “dead-time” (il tempo morto tra lo spegnimento di un transistor e l’accensione dell’altro) così ridotto, che la distorsione di incrocio (la peggiore che un finale possa generare) e gli artefatti di commutazione sono stati spinti ben oltre la soglia del rumore di fondo.

Oggi, un modulo Hypex NCx500 offre una trasparenza che fa impallidire blasonati finali in Classe AB da 50 kg. Ma l’audiofilo è un animale abitudinario e una volta che ha deciso che una tecnologia è “fredda”, ci vorranno tre generazioni di prodotti perfetti per fargli cambiare idea. La verità è che spesso confondono la mancanza di distorsione con la freddezza. Sono così abituati al calore pastoso (distorsione armonica di secondo ordine) dei loro valvolari o dei vecchi Classe A, che la pulizia assoluta della Classe D moderna suona alle loro orecchie come “vuota”. Non è vuota; è semplicemente fedele.
Il feticismo del peso e del calore: se non pesa 40kg, non è alta fedeltà
Qui entriamo nella psicologia pura, o forse addirittura nella patologia. Nell’audio hi-end, spesso il valore percepito è direttamente proporzionale alla massa fisica dell’oggetto e alla quantità di calore dissipato. Un amplificatore deve essere un monolite di alluminio spazzolato, deve avere dissipatori alettati taglienti come rasoi e deve richiedere due persone per essere spostato. Se accendendolo non si abbassano le luci del quartiere, non è “potente”.
La Classe D viola totalmente questo dogma. Grazie a un’efficienza che supera il 90% (contro il 25% scarso di un Classe A o il 60% di un AB), non ha bisogno di dissipatori enormi né di trasformatori toroidali grandi come ruote di scorta. Un finale stereo da 400W per canale su 4 ohm, come un assemblato Audiophonics basato su tecnologia Purifi, pesa quanto un dizionario e sta in una scatola da scarpe.

Per l’audiofilo che ha speso 10.000 euro per un finale Krell o Pass Labs in pura Classe A, vedere una scatoletta che eroga la stessa potenza (con un fattore di smorzamento spesso superiore) è quasi un insulto personale. Semplicemente, non può accettarlo. Il suo cervello gli dice: “Leggero = Economico = Giocattolo”.
C’è anche una sorta di masochismo nell’audiofilia, per il quale si deve soffrire per ottenere il suono. La Classe D, democratica, efficiente, ecologica e leggera, toglie il “sacrificio” dall’equazione. E senza sacrificio, per lo snob, non c’è gratificazione. È la stessa logica per cui un orologio meccanico impreciso può arrivare a costare cento volte più di un quarzo perfetto. Ma mentre nell’orologeria si paga l’arte meccanica, nell’audio si dovrebbe pagare il risultato sonoro. Se il risultato è identico o superiore, il peso è solo un inconveniente logistico, non un pregio.
Il problema (ormai risolto) dell’interazione con il carico
Qui entriamo più nel tecnico, dove i detrattori più preparati si rifugiano per giustificare la loro avversione alla Classe D. L’argomentazione è la seguente: “Il filtro di uscita della Classe D interagisce con l’impedenza variabile del diffusore, modificando la risposta in frequenza sugli alti”.
Storicamente, questo era vero. I vecchi design in Classe D avevano il loop di controreazione (feedback) che prendeva il segnale prima del filtro di uscita LC. Poiché l’impedenza di un altoparlante varia con la frequenza crescendo progressivamente sugli alti, il filtro interagiva diversamente a seconda del carico, causando picchi o attenuazioni udibili nella gamma altissima.
Ma usare questa scusa oggi è come lamentarsi che le auto a iniezione elettronica non partono d’inverno perché ci si ricorda dei carburatori del 1970. L’architettura moderna, come quella introdotta da Putzeys con Ncore e perfezionata con Purifi, utilizza un loop di controreazione globale che include il filtro di uscita e i morsetti dei diffusori.

Il sistema “vede” l’errore introdotto dal filtro e lo corregge in tempo reale. Il risultato? L’impedenza di uscita è talmente bassa (nell’ordine dei micro-ohm) e il Damping Factor così alto che l’amplificatore è totalmente agnostico rispetto al carico. Che voi ci colleghiate un diffusore planare Magnepan ostico o un Klipsch sensibilissimo, la risposta in frequenza rimarrà piatta.
Eppure, nei circoli esoterici, si continua a mormorare che la Classe D non pilota bene i carichi difficili. È una menzogna tecnica smentita da qualsiasi misura di laboratorio indipendente e, anzi, spesso è proprio la Classe D, con la sua riserva di corrente brutale, a svegliare diffusori “pigri” che con amplificatori valvolari dal suono “magico” sembravano difettosi.
La sindrome della mancanza di risoluzione ai bassi livelli
L’ultimo bastione del pregiudizio è il concetto nebuloso di “micro-dettaglio” o “ambienza”. Secondo i critici, la Classe D è sì potente e dinamica, ma nei passaggi pianissimo e nel decadimento delle note perde informazioni, quasi come ci fosse un buco nero dove invece dovrebbe esserci l’aria della sala di registrazione.
Questa è forse la critica più insidiosa perché fa leva sulla psicoacustica. I detrattori sostengono che il rumore di commutazione ad alta frequenza, pur essendo inudibile, crei distorsione di intermodulazione (IMD) che “sporca” la banda audio velando i micro-dettagli. Ancora una volta, bisogna guardare agli sviluppi tecnologici più recenti e non a quelli degli albori. La tecnologia GaN FET ha permesso di spingere le frequenze di switching verso il MHz, mentre i design a feedback multiplo hanno ridotto la distorsione di intermodulazione a livelli che sfidano le capacità di misura degli strumenti, figuriamoci dell’orecchio umano.

La verità è spesso l’opposto. Gli amplificatori tradizionali (specialmente i Classe A/B non controreazionati o a valvole) hanno infatti un rumore di fondo (hiss, hum di alimentazione) molto più elevato rispetto al “nero infrastrumentale” (l’assenza di rumore di fondo o interferenze tra una nota musicale e l’altra o durante le pause musicali) di un buon Classe D moderno.
Quello che gli audiofili chiamano “aria” o “micro-dettaglio” nei loro amati sistemi vintage è spesso, ironicamente, rumore o distorsione armonica a basso livello che il cervello interpreta come calore o presenza. Quando ascoltano un NAD M33 o un Marantz Model 30 (che usa moduli Hypex nel finale), il silenzio è reale. E quel silenzio spaventa. Se la nota finisce, finisce e non c’è più quella coda di risonanze calde a cui sono abituati.
La Classe D è infatti spietata e se la registrazione è secca, suonerà secca, mentre se è ricca, suonerà ricca. Per chi ha costruito un impianto basandosi sulla compensazione dei difetti (un ampli caldo per aggiustare diffusori brillanti, cavi “equalizzanti”), la neutralità assoluta è un difetto, non un pregio.
© 2025, MBEditore – TPFF srl. Riproduzione riservata.